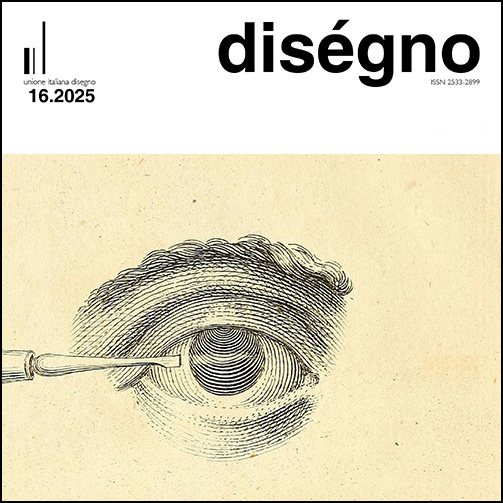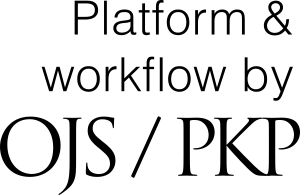I Songe, la Grande Onda di Kanagawa e ISOTYPE. Note sul disegno come linguaggio naturale, culturale e universale
DOI:
https://doi.org/10.26375/disegno.16.2025.6Parole chiave:
linguaggio naturale, linguaggio culturale, linguaggio universale, apprendimento, comunicazioneAbstract
Il contributo propone un framework teorico per l’analisi del disegno, radicato all’interno degli studi di psicologia e arricchito da esperienze significative di comunicazione visuale, sia contemporanee che storicizzate. Tale approccio si giustifica considerando il disegno di architettura come una specifica declinazione del disegno inteso come linguaggio ampio, permettendo così di trasferire al campo
architettonico molte osservazioni fondamentali sulla natura, le funzioni e i processi del disegno già esplorate in contesti generali.
Saranno esposti esempi rilevanti che illustrano le tre principali dimensioni del disegno quali linguaggio naturale, culturale e universale, con particolare attenzione ad alcuni studi degli anni ’60 e ’70 che, seppur in parte superati, risultano ancora fondamentali nello studio delle immagini e dei disegni.
Il quadro teorico complessivo verrà quindi declinato nel contesto specifico del disegno di architettura, evidenziando come esso inglobi e utilizzi in maniera integrata le tre dimensioni linguistiche sopra delineate.
Il contributo si concluderà con una definizione articolata dei caratteri distintivi del disegno inteso come linguaggio naturale, culturale e universale, ponendo le basi per future riflessioni teoriche e pratiche sul disegno inteso come linguaggio.
Riferimenti bibliografici
Anceschi, G. (1992). L’oggetto della raffigurazione. Milano, IT: Etaslibri.
Arnheim, R. (1954). Arte e percezione visiva. Milano: Feltrinelli.
Bertin, J. (1967). Sémiologie graphique: Les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris: Gauthier-Villars.
Case, R., Okamoto, T. (1997). The Role of Central Conceptual Structures in the Development of Children’s Thought. Chicago: University Of Chicago Press.
Di Napoli, G. (2011). Che cos’è un disegno e perché si disegna. In Rivista di estetica, 47, 61-81. https://doi.org/10.4000/estetica.1955.
de Rubertis, R. (1994). Il disegno dell’architettura. Carocci: Roma.
Durand, G. (2013). Le strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia generale (2a edizione; edizione originale pubblicata nel 1973). Dedalo: Bari.
Freud, S. (2010). Tratti arcaici e infantilismo del sogno. In Introduzione alla psicoanalisi. Prima e seconda serie di lezioni, pp. 186-198. Torino: Bollati Boringhieri.
Kennedy, J.M., Ross, A.S. (1975). Outline picture perception by the Songe of Papua. In Perception, 4, 391-406. https://doi.org/10.1068/p040391.
Kellogg, R. (1969). Analisi dell’arte infantile. Una fondamentale ricerca sugli scarabocchi e i disegni dei bambini. Milano: Emme Edizioni.
Lowenfeld, V., Brittain, W.L. (1967). Creatività e sviluppo mentale. Firenze: Giunti.
Luquet, G.H. (1969). Il disegno infantile. Educazione all’immagine per la scuola materna ed elementare. Roma: Armando.
Luigini, A., Moretti, M. (2019). L’attualità di Otto Neurath. Da ISOTYPE al Visual Journalism per un racconto visuale della società. In XY. Studi sulla rappresentazione dell’architettura e sull’uso dell’immagine nella scienza e nell’arte, 3(6), 74-93. https://doi.org/10.15168/xy.v3i6.112.
Menchetelli, V. (2013). Ubiquità di un’atopia. Il linguaggio universale Isotype e la riforma della comunicazione visiva. In P. Belardi, A. Cirafici, A. di Luggo et al. (Eds.), Atopie, pp. 159-164. Roma, IT: Form Act.
Pizzo Russo, L. (2015). Genesi dell'immagine. Milano: Mimesis.
Willats, J. (2005). Making sense of children’s drawings. Leicester: Institute of Education, University of Leicester.
##submission.downloads##
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2025 diségno

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.